di Margherita Mordenti, 3BA (Liceo Scientifico Scienze Applicate)
Il cinema nasce nel 1891 in bianco e nero e senza sonoro. Dai primi cortometraggi cinematografici dei fratelli Lumière ne è passato di tempo, e inevitabilmente molte cose sono cambiate; dal 1917, data di nascita di Technicolor, il bianco e nero diventa gradualmente sempre meno usato, mentre nel 1927, con l’uscita di The Jazz Singer, si segna la nascita dell’era del cinema sonoro.
Spesso associamo il bianco e il nero al cinema del passato, al periodo muto ed alla vecchia Hollywood; eppure non c’è niente di più sbagliato. Le immagini in bianco e nero continuano a esercitare il loro fascino eterno: non è infatti casuale la scelta di alcuni registi contemporanei che continuano a preferirlo per i loro film, nonostante la possibilità di girare a colori.
Già Woody Allen con Manhattan, o Steven Spielberg con Schindler List, ci hanno fatto capire che il cinema in bianco e nero non è mai stato destinato a morire.
In questo articolo parlerò dei quattro film in bianco e nero che, per una ragione o per un’altra, hanno fatto la storia del cinema. Sono quattro film completamente diversi tra loro, l’unica cosa che li accomuna è proprio il fatto di essere in bianco e nero.
Casablanca

Il primo titolo non può che essere Casablanca, uscito nel 1942, diretto da Michael Curtiz. Parliamo di un racconto cinematografico dal fascino immortale, conosciuto da tutti (persino da chi non l’ha visto) che ha come protagonisti Ingrid Bergman nei panni di Ilsa e Humphrey Bogart nei panni di Rick, coinvolti nel triangolo amoroso più celebre della storia del cinema.
Durante la Seconda Guerra mondiale, al Ricks’ bar di Casablanca, gestito da Eric Blaine, c’è di tutto: musica, risse, seduzione, gioco d’azzardo, amore, patriottismo, spionaggio, ufficiali francesi e tedeschi. L’atmosfera si fa ancora più tesa quando vi compaiono Victor Laszlo, eroe della resistenza, e la moglie Ilsa, ex fiamma -mai spenta- di Rick in cerca di due “lettere di transito” per lasciare il Marocco; ci penserà Rick a procurarle riscoprendo dentro di sé quell’impegno morale che una patina di cinismo sembrava aver fatto scomparire.
Un film che ormai è leggenda al di là di qualsiasi considerazione estetica, con un Bogart mitico nella parte che in origine doveva essere di Ronald Reagan, con le note di As Time Goes By che possono solo accompagnare la meraviglia di Casablanca. Umberto Eco, riguardo al film, ha affermato: “Quando tutti gli archetipi rompono senza decenza, si raggiungono profondità omeriche. Due cliché fanno ridere cento commuovono”.
Sunset Boulevard
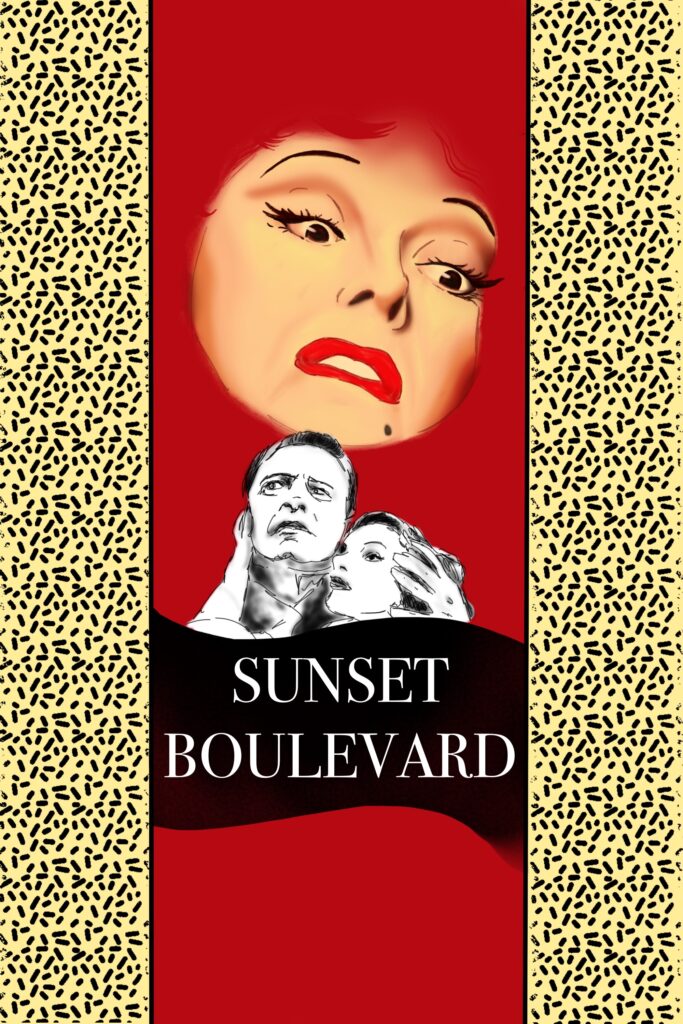
Sunset Boulevard (Viale del Tramonto) è un film del 1950, diretto da Billy Wilder che racconta, in una vicenda tra il tragico e il comico, il fenomeno del divismo che stava spopolando nella Hollywood di quegli anni.
La trama è molto semplice: mentre il suo cadavere galleggia nella piscina di una villa, la voce fuori campo di Joe Gillis (William Holden) ripercorre la storia della sua relazione con Norma Desmond (Gloria Swanson), grande attrice del passato che vive rinchiusa nel ricordo di una popolarità ormai sfumata. Joe inizia a convivere con la ricca Diva di Hollywood che invece lo vuole sfruttare per rilanciarsi. Gillis ne diventa il mantenuto, l’amante ed infine la vittima.
La semplicità della trama è sostenuta da una nuova struttura narrativa, con il mezzo di un flashback impossibile, per cui il pubblico sa già da subito come andrà a finire la storia.
È la prima volta che un narratore onnisciente introduce il racconto di un morto. Un paradosso stilistico che è una delle più grandi trovate della pellicola, insieme all’utilizzo della profondità di campo ed al chiaroscuro capace di deformare l’immagine.
Fin dall’inizio, Wilder stabilisce un tono di cinismo e black humor, contaminando il noir con atmosfere quasi horror: uno dei film più crudeli su Hollywood, e uno dei più affascinanti viaggi nella decadenza, che mescola finzione e realtà. Wilder riesce a fermare il tempo introducendo il personaggio di Norma Desmond, interpretata dalla grande diva del muto Gloria Swanson, elegante e sofisticata proprio come negli anni in cui Cecil De Mille (IL regista del cinema muto) le garantì il successo. La Swanson, che di fatto recita la caricatura di se stessa, interpreta una donna di cinquant’anni che non riesce ad accettare la fine della sua carriera e la sua esclusione dopo l’avvento del sonoro. Nonostante la crudeltà riservata ai fini del racconto, Wilder tratteggia il personaggio di Norma Desmond con una tenerezza struggente.
Il fenomeno del divismo contribuì all’analisi sessuale e psicoanalitica del significato della pellicola, secondo cui la star era definita dalla sua esistenza al di fuori del film. Il culto di Rodolfo Valentino, a oggi, rimane forse l’esempio più lampante.
Von Stroheim (Max, il maggiordomo) è un ex regista che aveva davvero diretto la Swanson nei film che lei fa proiettare nella villa e in “Viale del tramonto” il senso di “adorazione” per Norma da parte di Max è la più grande prova d’amore che Wilder riservi al cinema del muto, e lo si può capire dalla frase conclusiva pronunciata da Norma: “non esiste altro, solo noi e la macchina, e nell’oscurità il pubblico che guarda in silenzio. Eccomi De Mille, sono pronta per il mio primo piano.”
Scritturando il personaggio di Betty, Wilder compie la più grande delle meraviglie: la storia d’amore tra lei e Joe confrontata con quella tra lo stesso Joe e Norma Desmon raffigura il desiderato passaggio tra il cinema del muto e quello del nuovo cinema classico hollywoodiano, al quale Wilder lancia una frecciatina: “io penserei di tralasciare tutto il lato psicanalisi, il pubblico non vuole pensar troppo“. La risposta di Joe/Billy non si lascia attendere: “sì, ma oggi la moda è quella!”. Questa risposta di Wilder rappresenta l’ennesima rivelazione sul cinema americano della seconda metà degli anni Cinquanta, basato sulla psicanalisi e sul sesso, basti pensare alle pellicole che avranno come protagonisti James Dean e Marlon Brando.
Tra le frasi simbolo del suo capolavoro del 1950, forse la più leggendaria è senza dubbio la confessione superba di Norma: “Io sono sempre grande, è il cinema che è diventato piccolo“.
Nel 1950, anche grazie a Billy Wilder, il cinema era ancora Grande.
A Streetcar Named Desire
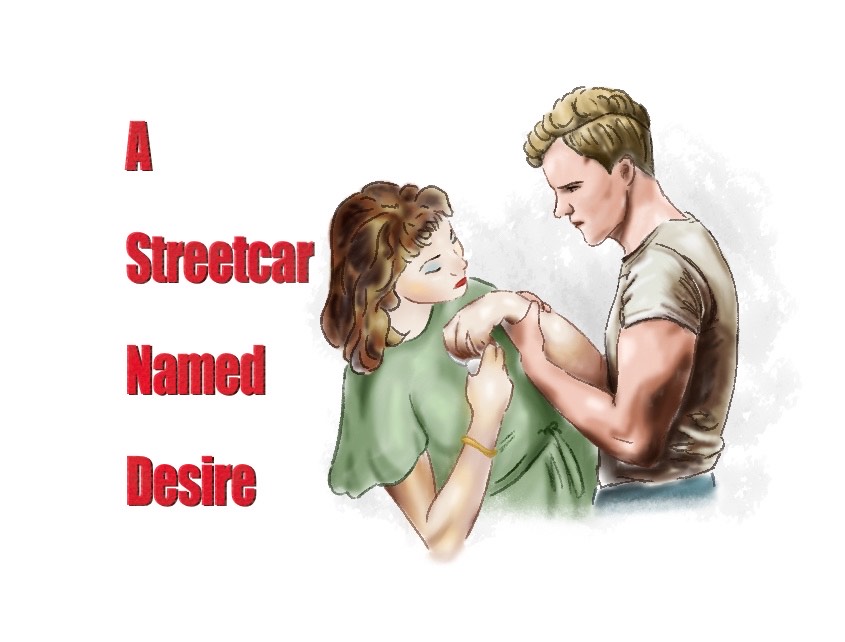
L’emblema dei film costruiti sul sesso e sulla psicanalisi su cui ironizza Billy Wilder è “A Streetcar Named Desire” (un tram che si chiama desiderio), un film del 1951, diretto da Elia Kazan, adattamento cinematografico dell’omonima opera di Tennessee Williams, un capolavoro assoluto del cinema. Con questo film Marlon Brando, interpretando lo stesso ruolo recitato a teatro, inizia la sua folgorante carriera.
È la storia di Blanche DuBois (Vivien Leight), figlia di un’aristocratica famiglia del Sud oggi in rovina, che si trasferisce a New Orleans dalla sorella Stella. Tra suo marito Stanley Kowalski (Marlon Brando) e Blanche nasce un’attrazione erotica basata sul disprezzo reciproco: Blanche non sopporta la volgarità del cognato, lui odia l’atteggiamento superficiale di lei e il suo falso senso di superiorità. Lui si fa scudo con la propria aggressiva virilità, mentre lei, debole di animo, inevitabilmente non potrà che soccombere alle crudeltà altrui.
Quando uscì per la prima volta nei teatri, Un Tram Che Si Chiama Desiderio fece non poco scalpore, dai temi trattati tra cui anche l’omosessualità (parte tolta nella versione cinematografica) all’onnipresente erotismo dei personaggi che si ritrovava in tutto, dalle magliette sudate ai gesti dei personaggi.
Kazan, rischiando con la sua versione cinematografica di diluire il dramma in commedia, riesce invece a rendere l’opera straordinariamente moderna, in cui sul realismo domina il senso onirico dell’opera. Le scenografie perdono qualunque dato naturalistico per assumere le sembianze di un incubo barocco.
In questo senso, il film può quasi essere considerato un’opera sperimentale, per come si pone consapevolmente sotto il segno dell’eccesso, sempre a un passo dallo sconfinamento nel melodramma o nell’opera lirica.
A Streetcar Named Desire rappresenta il trionfo del metodo Stanislavskij: nessuno era mai riuscito prima d’ora a rappresentare così bene le mille sfaccettature di un personaggio.
Elia Kazan è stato l’unico ad osservare l’opera di Tennessee Williams dalla giusta prospettiva: in un Tram che si chiama desiderio ci ritrova una tragedia poetica. La vera Blanche è da ricercare nelle ossessioni del suo autore, di cui condivide i desideri e le fantasie.
In questo film, differentemente dalle sue opere precedenti, la macchina da presa non è un occhio che riflette la realtà sociale del tempo, bensì una sonda introspettiva capace di portare alla luce la fonte più viva delle emozioni: la crudeltà nei rapporti interpersonali, il realismo violento anche nei costumi (magliette sporche, corpi sudati e volti impiastricciati), i ventilatori sempre presenti che al posto di dare respiro, lo tolgono. Questa corporeità esasperata, questa tensione verso gli oggetti fa sì che i corpi non rappresentino la storia, perché sono essi stessi la storia.
In questo modo si capisce quanto “Un tram che si chiama desiderio” abbia significato per il suo autore, diventando il simbolo dell’inclinazione verso un nuovo tipo di racconto, nel tentativo di esplorare le dinamiche nascoste dell’inconscio e del desiderio.
Il settimo sigillo
Basta spostarci di pochi anni, in Svezia, per scoprire una delle meraviglie assolute del cinema internazionale, (so di averlo detto per ogni film, ma è la verità). 1957, Ingmar Bergman, uno dei più grandi registi del panorama europeo, dà vita al suo capolavoro, Il settimo sigillo. Antonius Block torna dalle crociate con il suo scudiero, salvo scoprire che le sue terre sono devastate dalla miseria e dalla peste. Un’inquietante figura, la Morte, reclama la sua anima, ma Block riesce a prendere tempo.
Il film inizia e finisce con i versetti 1-2 del capitolo 8 dell’Apocalisse di San Giovanni: “Quando l’agnello aprì il settimo sigillo, nel cielo si fece un silenzio di circa mezz’ora e vedi i sette angeli che stavano dinnanzi a Dio e furono loro date sette trombe”.
Questo film inaugura il tema del silenzio di Dio, e la collaborazione con Max Von Sydow che durerà per tutti i prossimi film del regista.
Nell’apparente semplicità di una fiaba allegorica dell’orrore, il film trasmette una magica inquietudine.
La presenza di umorismo e terrore, negli incontri con la Morte, forniscono all’umanità e al Cinema il dogma dell’assenza di certezze.
Il senso di isolamento di una collettività in balia degli eventi è l’elemento centrale nell’impostazione dei toni di Bergman; la morte è in agguato e non ci sono scappatoie. Lo scontro contro la Morte è ricco di linee di dialogo geniali che si soffermano sulla netta convinzione di un mondo ultraterreno. L’intento è quello di creare tensione emotiva, ben sciolta da un atto conclusivo di rara bellezza espressiva, che va a manipolare una pagina storica del XIV secolo svedese, dando l’impressione di trovarsi di fronte ad uno specchio che riflette i drammi esistenziali contemporanei. Distante da qualsiasi manierismo, Bergman rende il film pregevole e indimenticabile, un vero e proprio emblema della grandezza della tradizione cinematografica svedese. In Bergman l’accecante sete di conoscenza di uomini destinati a morire ha un valore meditativo presente nei temi esposti: il conflitto tra ragione e sentimento, la ricerca della felicità, e i piaceri carnali. Nel film si respira un’atmosfera irripetibile, ricca di contrasti impressionanti che ipnotizzano e seducono lo spettatore come nelle chine medievali raffiguranti streghe, saltimbanchi, flagellanti e crociati, i dipinti di Dürer, i Carmina Burana di Carl Orff, Cervantes, Strindberg, Shakespeare e la fobia atomica, Dies Irae di Dreyer e i versi dell’Apocalisse sul Settimo Sigillo che, aperto, svelerà il mistero della vita.
Il settimo sigillo rappresenta un capolavoro sia nell’uso pittorico del bianco e nero sia nella riflessione sulla vita e la morte, simboleggiata dalla famosa “partita a scacchi”. Inoltre anticipa il motivo dello specchio e per la prima volta analizza, evoca e trasmette l’angoscia dell’individuo di fronte al vuoto senso degli eventi soprattutto in rapporto con il mondo circostante, legato agli orrori della vita e all’indifferenza del soprannaturale. L’ossimorica, meravigliosa “danza della morte” chiude il cerchio sull’agonia della credenza.



Lascia un commento